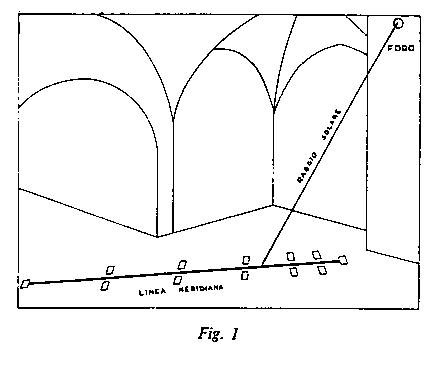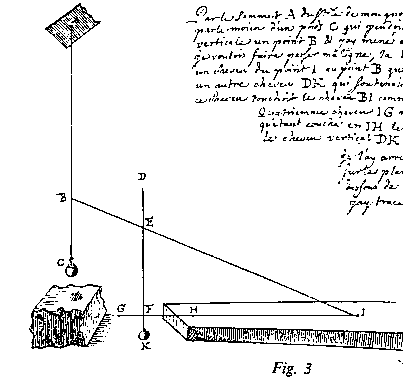Le meridiane
filari
Nicoletta Lanciano
Università "La Sapienza" di Roma
Abstract. The first part of this article
describes the working of the wire sundials and their origin. The
earliest wire sundial of which we know, is in France: the
astronomer J. N. Delisle had it built in Paris in 1713. The text
reports a long passage from his
notes.
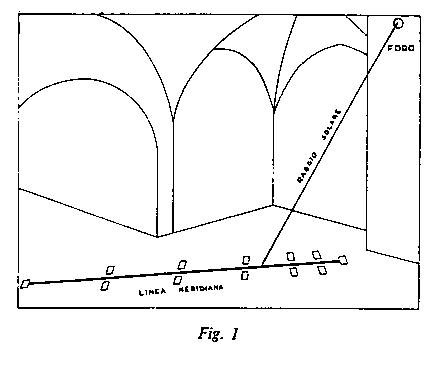
Le torri dei due antichi osservatori di via Romana a Firenze e di
Palazzo Poggi a Bologna, racchiudono, ciascuna, una meridiana orizzontale.
La meridiana di Bologna, rifatta nel 1741, mostra ancora i resti di un
dispositivo a filo installato nel 1726. La meridiana di Firenze porta la
data del 1784. Si vedono nella sala, nelle pareti a nord e a sud, da una
parte e dall'altra della linea meridiana, due supporti di ferro la cui
funzione può non essere chiara ad un primo impatto. Eppure si tratta,
anche in questo caso, dei resti di una meridiana filare, meno nota di
quella di Bologna.
Le meridiane orizzontali
Una linea meridiana è la
materializzazione di un tratto del meridiano locale.
Meridiano
viene dal latino meridies e cioè "metà del giorno": il Sole
infatti attraversa il cielo meridiano, a mezzogiorno: se sulla linea
meridiana è posto uno gnomone, come ad esempio a piazza San Pietro a
Roma, quando la sua ombra la attraversa indica il mezzogiorno
locale.
Ma all'interno delle chiese, degli osservatori e dei
palazzi si trovano i veri gioielli: le linee meridiane in cui la
protagonista è la luce stessa del Sole. Anche in questo caso una
linea orientata nord-sud è tracciata in terra: e in alto, nella
parete a sud, un fiorellino permette al Sole di entrare nella
sala.
Il dispositivo di una meridiana di tipo filare consiste in
un sottile filo metallico, teso tra due supporti, e allineato con
precisione secondo la linea nord-sud, in una stanza buia. |
|
Il filo può trovarsi ad una distanza
arbitraria dal pavimento purché abbastanza vicino a questo. Il foro
eliottrico deve essere aperto sulla verticale dell’estremo sud del
filo. Intorno al momento del mezzogiorno locale l'immagine del Sole
si sposta sul pavimento da ovest verso est. Poggiato un foglio
bianco sotto il filo per raccogliervi l'immagine del Sole, si segna
il momento preciso in cui il bordo del cono di luce è tangente al
filo, e l'ombra di questo appare sul foglio. L'ombra del filo è di
nuovo tangente al bordo del cono di luce dalla parte opposta dopo
qualche minuto: la media dei due tempi dà l'istante del mezzogiorno
con un errore probabilmente inferiore al secondo.
Si tratta quindi, in questo caso, di una meridiana in cui la
luce, del raggio del Sole, e l'ombra, del filo, sono entrambi
presenti. |
L'origine delle meridiane filari
La più antica meridiana di tipo filare di
cui si ha notizia è quella che l'astronomo Joseph Nicolas Delisle
costruì a Parigi nell'Osservatorio della Torre del Luxembourg nel
1713.
Nato a Parigi nel 1688, Delisle studiò al Collegio Mazarin;
in seguito all'eclisse di Sole del 12 marzo 1706, che colpì
vivacemente la sua curiosità, intraprese studi di astronomia. Nel
1710 ebbe il permesso da M. le Duc d'Antin (sovrintendente dei
Palazzi della Corona), di stabilirsi nella cupola che si trovava
sopra il portone principale del palazzo del Luxembourg dal lato
della Rue de Tournon, dove due anni più tardi stabilì il suo
osservatorio.
L'osservatorio era costituito dalla sala rotonda
coperta dalla cupola, di 8 m di diametro all'interno e di 4,5 m di
altezza fino all'inizio della parte emisferica. La sala aveva otto
aperture, fino a terra, corrispondenti ai lati di un ottagono
regolare: la stessa forma che, come vedremo in seguito, si ritrova
|
|
nell'Osservatorio di Eger in
Ungheria.
Ma Delisle, dopo essere stato ammesso a far parate
dell'Academie, fu obbligato ad abbandonare l’Osservatorio del
Luxembourg nel 1715 per ordine della Duchessa de Berry. Nel 1724
fece un viaggio a Londra durante il quale incontrò Newton e Halley.
Lo zar Pietro il Grande, che lo conobbe durante un soggiorno in
Francia, lo invitò a fondare una scuola di astronomia in Russia.
Delisle partì per Pietroburgo nel 1724 e vi restò 22 anni. Tornato
in Francia nel1747, riprese le sue funzioni all'Academie. Stabilì
allora il suo nuovo osservatorio su un pianerottolo sopra la scala
dell'Hotel de Cluny, nella via Mathurins. Morì a Parigi nel 1768
dopo avere pubblicato molte opere di rilievo. Tra i suoi allievi ci
sono Lalande, a cui aveva ceduto al suo ritorno in Francia nel 1747
l'osservatorio del Luxembourg, e Messier. |
Gli strumenti di cui
disponeva Delisle all’Osservatorio del Luxembourg erano:
- un pendolo a cicloide, costruito da H. Balthazar, alla fine
del 1711, simile a quello che Huygens descrisse nel suo
Horologio Oscillatorio;
- una macchina parallattica;
- uno gnomone con meridiana ordinaria tracciata sul pavimento;
- un cannocchiale murale.
Sul
modo in cui ho regolato il mio pendolo |
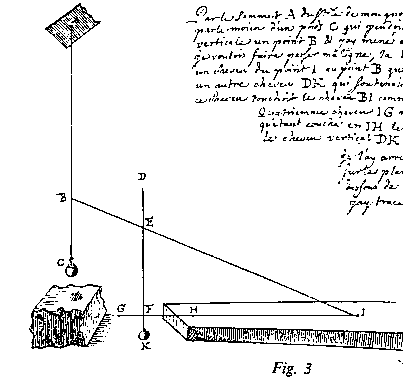 |
Il tempo dell'orologio era allora "trasportato" da un luogo di
osservazione all'altro dove si trovavano i pendoli fissi, attraverso
orologi a secondi che invece erano mobili. Un'ora del pendolo di Delisle
veniva cosi confrontata con un'ora del pendolo di M. Le Chevalier de
Louville, che era esattamente regolato sul tempo vero attraverso le
altezze corrispondenti del Sole.
Il filo, dunque, come Delisle precisa in un testo delle "Memoires de
l'Academie" del 1719, deve essere fino e unito: ci si può servire per
questo di un gran numero di capelli annodati tra loro, e per rendere
l'immagine più distinta possibile, è utile rendere la sala
dell'osservazione ben scura. Non ha alcuna importanza che il filo sia ben
teso o che sia curvo "a causa della pesantezza", che sia perfettamente
orizzontale o invece inclinato: è solo necessario che sia tutto nel piano
del meridiano.
Per rendere l'immagine del Sole più distinta possibile, si può fare il
diametro del foro circa della millesima parte dell'altezza dello gnomone,
come si osserva nel grande gnomone di Bologna [3], e questa proporzione è
la più vantaggiosa anche per i piccoli gnomoni; osservandoli ci si accorge
distintamente che la penombra che circonda l'immagine del sole ha la
larghezza del diametro del foro; quando il Sole ha delle macchie
considerevoli, si possono vedere anche nella sua immagine.
Nel periodo in cui si trovò a Petersbourg, Delisle raccolse le sue
osservazioni, dal 1726 al 1747, in 6libri: nel terzo libro sono raccolte
le osservazioni fatte con gli gnomoni e la descrizione di questi (in
cinque capitoli).
Nei primi tre capitoli descrive lo gnomone maggiore dell'Osservatorio
Superiore, con un obiettivo di 32 pieds e con il fuoco di 10
pouces.
L'altezza del foro era di 25 pieds.
Nel quarto capitolo descrive le osservazioni fatte con un secondo
gnomone dell'osservatorio superiore, e nel quinto capitolo è la
descrizione dello gnomone dell'osservatorio inferiore "nel quale
l'immagine del Sole è stata introdotta nella camera oscura da un foro
semplice aperto in una placca posta nel piano dell'equatore, che è servita
non solo alle meridiane filari orizzontali e verticali di questo
osservatorio, ma anche alle altezze meridiane del Sole, nei solstizi
d'inverno degli anni 1731-41 e molto tempo prima e dopo questi solstizi,
ricevendo l’immagine del Sole su una lastra verticale, distante circa 29
piedi dal foro" (manoscritto dell'Observatoire de Paris,
E1-1-(151-121)).
(I. Continua)
Note
[3] Si tratta della grande meridiana di San Petronio a Bologna
tracciata da Gian Domenico Cassini. |