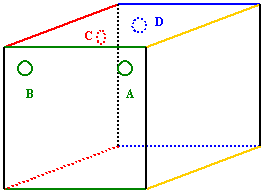|
Obiettivo
Rendersi conto che “la
luce” di per sé non è visibile: si vedono le sorgenti
primarie di luce e/o gli oggetti
illuminati (sorgenti secondarie).
|
|
Materiale
-
Due scatole: una con pareti interne nere, una con
pareti interne bianche (vedi dettagli costruttivi);
-
Una sorgente di luce, piccola e di bassa intensità
(vedi dettagli costruttivi);
- Fogli bianchi di carta o cartoncino.
|
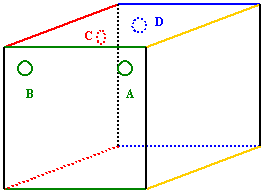
|
|
Come procedere
-
Inserire nel foro B di entrambe le scatole la
sorgente di luce.
-
Osservare l’interno delle scatole da ciascuno dei
fori A, C, D, una prima volta a sorgente spenta e una seconda volta a
sorgente accesa. Tenere sempre chiusi I fori da cui non si osserva.
-
Ripetere le osservazioni al punto 2 dopo aver
inserito nelle scatole un oggetto bianco (per esempio un cilindretto
ottenuto arrotolando un foglio A4), in posizione tale da essere visto
solo guardando dal foro A.
-
Oscurare la stanza, rimuovere da entrambe le scatole
la parete mobile, osservare affiancati I due interni a sorgente
accesa, con e senza oggetto bianco.
|
|
Cosa si vede
-
Quando la sorgente
è spenta e le scatole sono chiuse, guardando l’interno di
entrambe le scatole da qualsiasi foro, non si vede nulla (si ha
l’impressione di un buio totale).
-
Quando la sorgente
è accesa e le scatole sono chiuse si vedono cose diverse:
-
guardando nella scatola
a pareti bianche, si vedono in ogni caso le pareti della
scatola e, quando la porzione di spazio visibile li contiene,
anche la sorgente e/o l’oggetto bianco. L’intensità di
illuminazione di oggetto e pareti è maggiore nelle zone
prospicienti alla sorgente o ad essa più vicine, minore nelle
altre. Compare l’ombra dell’oggetto, nella zona ad esso
retrostante rispetto alla sorgente
-
guardando nella scatola
a pareti nere, dal foro A si vede l’oggetto bianco,
illuminato nella zona rivolta verso la sorgente; dal foro C non si
vede nulla; dal foro D si vede la sorgente.
- Quando la sorgente
è accesa e le scatole sono aperte è possibile osservare ciascuno
dei due ambienti nel suo complesso e valutare le differenze percettive
fra di essi. La scatola
con le pareti bianche appare più luminosa, al suo interno sono più
sfumati i limiti ed è meno accentuato il contrasto fra la parte di oggetto
illuminata direttamente e quella “in ombra”.
|
 |
|
|
Conclusioni ed interpretazione
L’insieme delle
osservazioni porta ad affermare che:
-
non è possibile
vedere nulla all’interno di un ambiente in cui non vi sia alcuna
sorgente di luce primaria e non possa penetrare luce dall’esterno;
-
anche in un ambiente
“pieno” di luce per la presenza di una sorgente primaria può
succedere di non vedere nulla.
Queste
evidenze sperimentali possono essere interpretate facendo le seguenti
ipotesi:
-
per vedere è
necessario che vi sia della luce che arriva agli occhi di chi guarda;
-
ciò che si vede è
l’oggetto che invia luce agli occhi, o perché è sorgente primaria
di luce o perché può rinviare nello spazio circostante parte della
luce che lo colpisce;
-
l’intensità della
luce rinviata dipende dall’oggetto: è massima per gli oggetti
bianchi e minima (al
limite non percepibile) per gli oggetti neri;
-
un ambiente con pareti
chiare appare più luminoso di un ambiente con pareti scure perché le
pareti si comportano come sorgenti secondarie e nel primo caso
diffondono una quantità di luce maggiore.
|
|